#26 Lazzaro non era davvero morto 🪨
E se vi dicessi che un biblista sostiene che Lazzaro in realtà non è mai risorto?
Lo sapevate che Gesù non ha mai detto a Lazzaro: “Alzati e cammina!”?
Partirei da qui. Molti confondono le parole che Gesù, secondo i Vangeli ha detto ad una persona paralitica, con quelle dette a Lazzaro. Gli avrebbe detto in realtà “Forza, coraggio, vieni fuori!”.
Ma facciamo un passo indietro.
Cosa significa mettere in discussione una certezza? Non per demolirla, ma per interrogarla, analizzarla, e magari trovare nuovi modi di comprenderla.
Per questo ogni tanto mi piace cercare testi che credo mi possano portare nuovi punti di vista o che siano in aperto contrasto con quello che mi pare di intuire. Mi concedo a volte di aprirmi a testi che non supportano le mie tesi, e anzi. Perché credo sia un bello stimolo.
Mi è successo anche qualche tempo fa con il libro Resurrezione Reincarnazione di Mauro Biglino. Pubblicato nel 2009 da Uno Editori, il testo esplora i concetti di resurrezione e reincarnazione nelle tradizioni religiose occidentali e orientali, analizzando le origini e l'evoluzione di queste idee nel tempo.
Ma soprattutto attraverso l'analisi dei testi sacri e delle tradizioni religiose, l'autore offre risposte sorprendenti che emergono dall'accesso ai codici più antichi, invitando i lettori a riflettere criticamente su credenze consolidate. Di fatto facendo emergere numerosi dubbi.
Tra tutti i contenuti del libro, sicuramente affascinanti, uno mi ha colpito in particolare. Ad un certo punto si parla infatti della resurrezione di Lazzaro. Lo ricordate?
La versione “ufficiale”: la resurrezione di Lazzaro
La resurrezione di Lazzaro è un episodio emblematico del Vangelo di Giovanni, precisamente del capitolo 11, ed è uno dei miracoli più noti di Gesù. Questa storia sottolinea il suo potere divino e la sua capacità di vincere la morte, ma ha anche un forte impatto simbolico legato alla fede, alla speranza e alla vita eterna.
Non è solo una dimostrazione di potere divino, ma anche una dichiarazione teologica e simbolica.
Lazzaro, fratello di Marta e Maria, sta male. Le sorelle fanno arrivare un messaggio a Gesù: “Signore, colui che tu ami è malato”. Gesù in quel momento si trova fuori città, ma, secondo il racconto, decide di aspettare comunque due giorni prima di partire. E quando raggiunse Betania, Lazzaro era già morto. Il Vangelo fa capire che Gesù conosceva bene sia Lazzaro, sia la sua famiglia, probabilmente era un simpatizzante, se non proprio un discepolo di Gesù.
Il Vangelo precisa che quando Gesù arriva, Lazzaro era già "da quattro giorni" nel sepolcro.
Quando arriva Gesù sembra molto colpito dal pianto e la disperazione delle sorelle di Lazzaro. Tanto che lo stesso Gesù si lascia andare ad un pianto.
A quel punto Gesù si reca alla tomba, una grotta chiusa da una pietra, e chiede di rimuoverla. “Lazzaro, vieni fuori!” dice Gesù a gran voce. E Lazzaro, esce dalla tomba vivo.
Questo miracolo è molto più di un semplice gesto di potere. Nel contesto del Vangelo di Giovanni, è il settimo e ultimo segno compiuto da Gesù, il culmine della sua missione prima della passione. Dimostra che Gesù è “la resurrezione e la vita” e prefigura la sua stessa resurrezione. Inoltre, ha una valenza escatologica: chi crede in Cristo non morirà mai davvero.
Da questo momento però Lazzaro non compare più nel prosieguo del Vangelo, né in alcun altro scritto del Nuovo Testamento.
I dubbi di Mauro Biglino.
Bene, per Mauro Biglino tutto questo è un errore di interpretazione. Secondo il traduttore, sono molti i passaggi dei testi sacri fraintesi, e il racconto evangelico su Lazzaro non farebbe eccezione.
Biglino interpreta questo episodio non come una resurrezione fisica, ma come un rito di reintegrazione di un adepto considerato "morto", non nel senso fisico, ma morale. Lazzaro sarebbe stato temporaneamente escluso dalla comunità degli iniziati e poi riammesso attraverso un processo di purificazione.
Ma in cosa consisteva questo rito? Biglino descrive un rituale in cui l’adepto veniva isolato in una cripta, immerso nel buio e nel silenzio, senza cibo né acqua, per un periodo di riflessione e purificazione interiore. Solitamente tre giorni. (Vi ricorda qualcosa?).
Biglino sottolinea anche l’importanza del contesto.
Un aspetto cruciale delle comunità iniziatiche era il legame tra i membri, che si definivano “fratelli”. Quindi qualcuno dica ai GenZ che con “bro” non si sono inventati nulla.
Per dare elementi concreti, Biglino cita la Didaché, un testo cristiano primitivo che descrive gli insegnamenti morali dell’epoca. La Didaché distingue chiaramente due vie: quella della vita, per chi segue gli insegnamenti, e quella della morte, per chi se ne allontana. Questa visione riflette un confine simbolico tra i membri della comunità e gli “esclusi”.
Biglino trova ulteriori conferme in altri Vangeli, citando un passo di Luca:
“E disse a un altro: ‘Segui me’. Ed egli disse: ‘Permetti a me di andare prima a seppellire padre mio’. Allora gli disse: ‘Lascia i morti seppellire i loro morti’” (Lc 9, 59-60).
Qui, Gesù sembrerebbe distinguere i “vivi”, cioè i suoi seguaci, dai “morti”, coloro che hanno abbandonato la via della salvezza.
Nel racconto di Lazzaro, le sorelle Marta e Maria sembrano rimproverare Gesù: se fosse stato presente, Lazzaro non sarebbe “morto”. Biglino evidenzia come questa morte non sia fisica, ma rappresenti un allontanamento spirituale.
Nel testo originale ebraico, l’espressione “Ki-az lo-met” indica una certezza: “non vi è dubbio che non sarebbe morto”. Biglino si chiede come la sola presenza fisica di Gesù avrebbe potuto in maniera certa prevenire la morte di Lazzaro, a meno che non si parli appunto di una morte simbolica, legata all’abbandono degli insegnamenti.
Biglino solleva anche una questione fondamentale: perché la resurrezione di Lazzaro è narrata solo nel Vangelo di Giovanni? Gli altri evangelisti ignorano un evento così straordinario perché lo ritengono poco importante? Come mai Lazzaro, presunta prova vivente del potere di Cristo, non appare più nei momenti chiave, come l’ingresso a Gerusalemme, il processo o la crocifissione? E che fine hanno fatto i testimoni dell’evento, citati da Giovanni?
Biglino cerca una spiegazione, richiamando lo storico Flavio Giuseppe e la sua opera Guerra giudaica. Durante l’assedio di Masada nel 73 d.C., Eleazar, comandante degli zeloti, pronunciò un appassionato discorso che spinse i suoi uomini al suicidio collettivo per evitare la cattura da parte dei romani. Flavio Giuseppe lo descrive come “un uomo potente, discendente da Giuda”, il quale si era opposto al censimento ordinato da Quirino.
Biglino suggerisce che questo Eleazar potrebbe essere il Lazzaro adulto, un uomo che da giovane aveva abbandonato la “via” e che Gesù aveva riportato nel movimento messianico. Questa ipotesi spiegherebbe perché i primi tre evangelisti, scrivendo prima della caduta di Masada, non ritennero rilevante raccontare la storia di un ragazzo reintegrato. Per Giovanni, invece, Lazzaro era più di un semplice adepto: era diventato un comandante noto e rispettato.
Inoltre il Vangelo di Giovanni è stato scritto in un periodo in cui le comunità cristiane erano già diffuse, ed è quindi plausibile che oltre a molte conversioni ci fossero anche molte persone che decidevano di lasciare questi insegnamenti.
E quindi la scelta di Giovanni potrebbe riflettere la necessità di recuperare chi si poteva allontanare dalle prime comunità cristiane. Secondo Biglino, il racconto di Lazzaro servirebbe proprio a illustrare il reintegro di un membro “eccellente”.
Perché porsi dei dubbi?
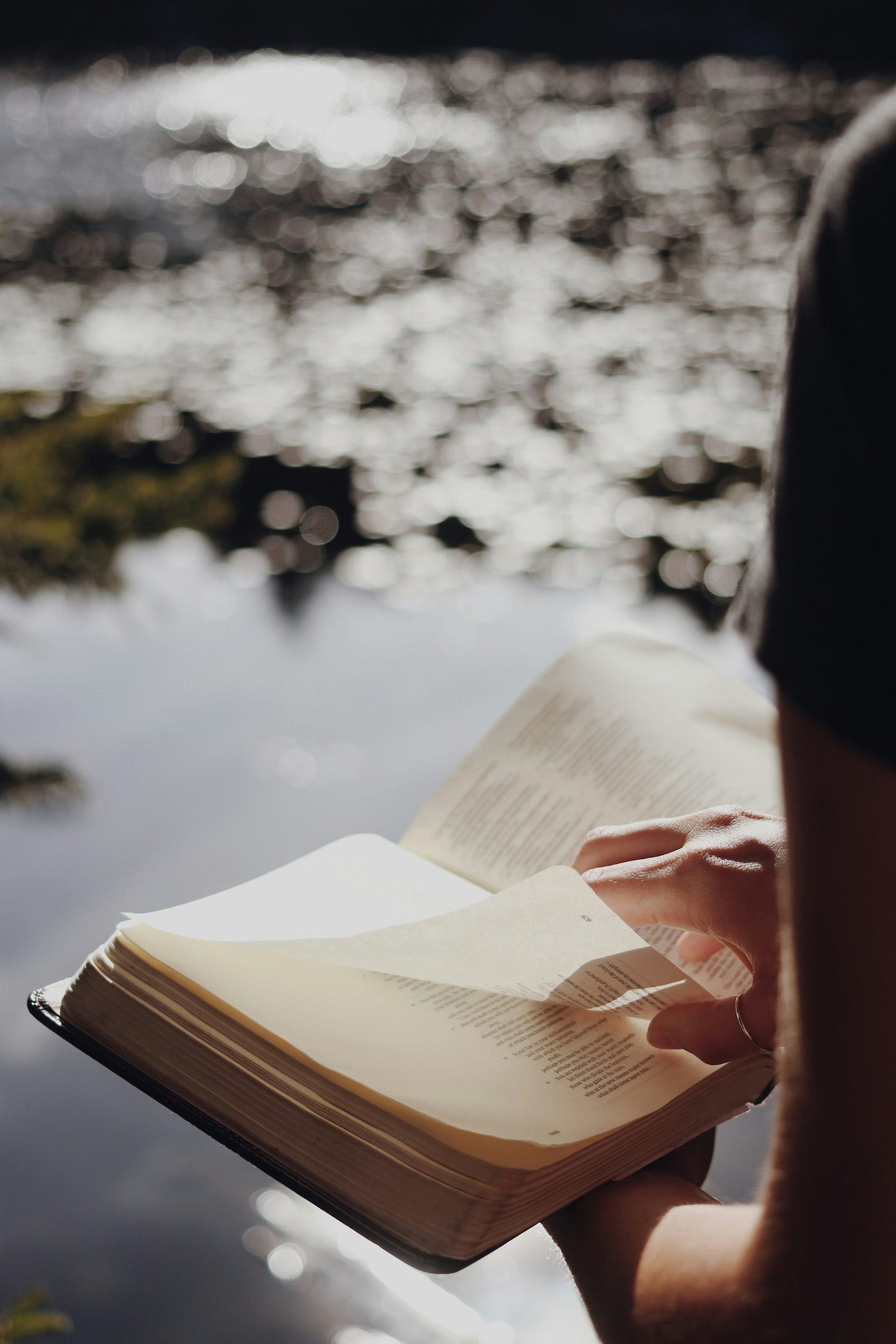
Cosa significa davvero mettere in discussione una certezza? Io credo non sia un atto di ribellione fine a se stesso, ma una forma di curiosità intellettuale, una tensione verso la comprensione più profonda. Significa accettare che anche le fondamenta più salde della nostra conoscenza possano essere riconsiderate, non per distruggerle, ma per esplorarle da nuove angolazioni e, forse, arricchirle.
Il racconto della resurrezione di Lazzaro è uno di quegli episodi che sfidano il confine tra fede e interpretazione, tra simbolo e storia. Mauro Biglino, con la sua prospettiva basata sull’analisi testuale, ci invita a spostarci oltre la narrazione tradizionale e ad abbracciare l’idea che molte delle storie che conosciamo possano celare significati più complessi, radicati in pratiche culturali e rituali antiche.
Questa rilettura, non sminuisce l’impatto del racconto, ma ne amplia la portata. Se accettiamo l’idea che la resurrezione di Lazzaro sia una metafora o un rito di reintegrazione, ci troviamo davanti a una rappresentazione potente di redenzione, trasformazione e appartenenza.
Riflettere sul concetto di resurrezione simbolica ci porta a confrontarci con la natura dell’identità e della trasformazione, di cui ho già parlato in passato.
La resurrezione, letta attraverso questa lente, diventa un processo interiore, una chiamata a ritrovare se stessi o a rientrare in contatto con un sistema di valori. L’isolamento nella cripta e il successivo ritorno rappresentano un ciclo che possiamo tutti riconoscere: momenti di crisi, di lontananza da chi siamo o da ciò in cui crediamo, seguiti da una rinascita che ci restituisce a noi stessi e agli altri.
In un certo senso, Lazzaro siamo tutti noi. La sua storia riflette l’esperienza umana universale di smarrimento e ritrovamento. E forse, proprio qui, risiede la forza del racconto evangelico: non nella cronaca di un evento miracoloso, ma nella sua capacità di parlare a qualcosa di profondamente umano.
Biglino ci sfida a guardare oltre il livello superficiale della narrazione.
Cosa significa vivere e morire?

Alla fine, il racconto di Lazzaro ci pone davanti a una domanda più ampia: cosa significa davvero vivere? Se la resurrezione è intesa non come un evento soprannaturale, ma come un processo simbolico, allora vivere significa trasformarsi continuamente, abbracciando ogni crisi come un’opportunità per rinascere. Significa accettare che, come Lazzaro, possiamo smarrirci, ma anche ritrovarci, con l’aiuto degli altri e con la forza delle nostre convinzioni.
E forse, in ultima analisi, è questo il messaggio più potente: che non siamo mai davvero soli nel buio della cripta. C’è sempre qualcuno che ci chiama, che ci invita a tornare alla luce. E quel qualcuno può essere la fede, un amico, una comunità, o persino una parte dimenticata di noi stessi.
In un mondo che sembra spesso privo di certezze, il racconto di Lazzaro ci ricorda che non dobbiamo temere la perdita o il cambiamento. Ogni fine è un nuovo inizio, anche ogni morte simbolica è un passo verso una rinascita. E forse, nel momento in cui rispondiamo al richiamo “Lazzaro, vieni fuori!”, non stiamo solo tornando alla vita: stiamo riscoprendo chi siamo davvero.
Se questo numero ti è piaciuto aiutami a far crescere questa newsletter, condividilo sui social o con chi secondo te potrebbe apprezzare. Grazie già in anticipo se deciderai di farlo.
E se ancora non l’hai fatto iscriviti per rimanere in contatto e non perderti nessun numero. Puoi farlo cliccando qui.
Piccolo disclaimer
Leggerenza non è e non vuole essere in alcun modo superficialità.
Il rispetto per le singole storie di perdita e di dolore non verrà mai meno.
Questo vuole essere uno spazio aperto di scambio, consapevolezza e curiosità.
Il viaggio è un work in progress.
Se qualcosa non è perfetto, be kind.







Ritorno a una vita nuova, può essere inteso come resurrezione dell'anima dopo la morte, quella fisica. In questo caso la lettura da parte di Biglino della storia di Lazzaro è davvero interessante, al punto da farci porre delle domande sulla veridicità delle traduzioni delle testimonianze evangeliche.